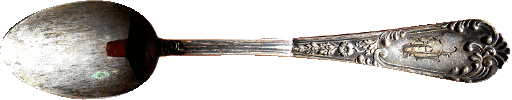La parola Tupone nel dialetto Sardo
Tratto dal libro: "CURIOSITÀ DEL VOCABOLARIO SARDO" di Antonio Senese
Tupa
Abbiamo avuto occasione di adoperare il vocabolo tupa che, come matta, vale «macchia». Ma il termine merita una trattazione più ampia, per la ragione che il lettore vedrà subito.
Il Wagner sostiene che esso deriva dalla radice tup (o anche 'up) che avrebbe avuto, in origine, il valore di «folto, denso» e simili. Nulla da eccepire circa la radicale; ma mi permetto di dissentire, almeno in parte, per il suo significato originario.
Comunque, è un fatto che da questa radice sono rampollati parecchi altri termini, oltre a quello di cui si è detto: sostantivi, aggettivi, verbi. I quali, poi, si sono dispersi in varie direzioni e vari modi, pur conservando, i più, qualche cosa del senso originario e la parentela che li lega. E, si intende, il suono fondamentale. Vediamo ora quelli che ci vengono in mente.
Prendiamo per primo upa, che vuol dire, grosso modo, «aspetto, apparenza» e, secondo lo Spano, «volume, ombra». Qualche esempio ce ne chiarisce il senso esatto. Di una donna formosa, di florido aspetto, e prospera presenza, si dice ancora chi hat solu sa upa, se, contrariamente a quel che mostra e lasci pensare, non ha alcuna resistenza al lavoro e si affatica subito: ma non lenet sustanzia.
Avviene sempre di intravedere all'improvviso, in casa o più spesso in campagna, di notte o al buio, una specie di ombra più o meno voluminosa, e indistinta, ferma o anche in moto. È l'incerta sagoma di un animale o di una persona, o di altra cosa imprecisa, indeterminata? Non si può dire di che cosa si tratti, al primo aspetto. Talché, nel dubbio, sorge un certo senso di paura, in noi, di fronte a questa cosa ignota, che ci appare inaspettatamente all'improvviso, e dai contorni vaghi. Potrebbe anche essere il nemico che ci attende all'agguato, per farci del male; o un'anima dannata, non ancora accolta per l'eternità nell'inferno, che vaga nella notte. Si dirà allora che si è vista una upa; addirittura una upa mala; anche se poi si constata che si tratta di un famigliare comparso nel buio della stanza, o di un bue che riposa, ruminando pacificamente, sulla nuda terra.
Il termine esiste anche al maschile: upu; e il suo derivato upuale, più comunemente nella forma di pubuale. Secondo lo Spano upu designa l'«attignitoio», un piccolo recipiente per attingere l'acqua dalla sorgente o da un tino. Di fatto nell'uso comune ha un senso generico più ampio: quello di recipiente per prendere o conservare acqua e altri liquidi, come il latte, negli ovili. Era comunemente di sughero, e immancabilmente aveva attorno diversi upittos, cioè piccoli upos, della capacità di due, tre litri. In un certo periodo della nostra storia, quello della tarda feudalità, era proprio una misura di capacità. Fra le varie contribuzioni alle quali erano tenuti i vassalli nei confronti del feudatario, vi era proprio quella, certo arbitraria, chiamata upittu de sos sórighes. Precisamente: i vassalli, oltre al laore de corte (se dovuto al feudatario), erano obbligati a consegnare anche unu upittu di grano, a compensare il ricevente del grano mangiato dai topi nei magazzini padronali!
S'upuale, o puale, o buale a seconda dei paesi, cioè il secchio, avrebbe il suo etimo, secondo lo Spano, nel latino aqualis, in cui è evidente la derivazione da aqua, «acqua». E invero la desinenza -alis, come in italiano, era normale in latino, e anche in sardo. Tuttavia io ritengo che l'origine vera sia proprio la radice di cui trattiamo, cioè (t)up; alla quale nell'uso abbiamo aggiunto appunto il suffisso -ali, -ale.
Una specie di cavolo viene indicata in sardo càule (a) upu. È il cavolo cappuccio, nel quale le foglie si sovrappongono, si raccolgono, più o meno fitte e compatte, una sull'altra, in modo da formare una specie di palla.
Riprendiamo ora il termine da cui siamo partiti: tupa, cioè, che come abbiamo già visto vuol dire macchia, cespuglio, ma in genere piuttosto voluminoso, e ampio, anche se sostanzialmente costituito sempre da un groviglio di fronde e rami, e rametti di poca consistenza.
Ma tupa chiamiamo anche il buco della serratura, il foro di entrata della chiave per smuovere la sbarra di chiusura e di apertura de su friscu: sa tupa de sa crae.
Da tupa sono derivati alcuni verbi. Tupare, intanto. Anche qui un esempio chiarirà il senso comune di questo verbo, che poi non è il solo, come vedremo dopo, a provenire da tupa. È noto che in ogni comune esiste il cosiddetto Regolamento di polizia rurale. Il quale, salvo le modifiche più o meno sostanziali apportatevi in seguito, rimonta dappertutto, anche se in genere negletto dagli amministratori, al 1865. (Se mal non ricordo era deliberato dai Consigli Provinciali, ma era sancito dal Re, per cui porta la firma del Re Galantuomo Vittorio Emanuele II). Orbene una delle disposizioni portate dal detto regolamento fa obbligo ai proprietari dei fondi frontisti alle strade pubbliche, chiusi con siepi vive, di recidere a primavera i rami che si protendono nelle strade campestri. Lo scopo è evidente: si voleva evitare che sas tupas ostruissero le vie, le... tupino: tupare su caminu.
Tupare vale anche «tappare»: tupa sa ucca de su carradellu; su mustiu hat finidu de buddire (la fermentazione lenta dei mosti nelle botti). Cosi, anche istupare ha un duplice significato. «Togliere il tappo», intanto, dal recipiente ove era stato apposto o applicato: istupa su carradellu, sa damigiana ecc. E l'altro di «uscire», e non da un luogo qualsiasi; ma dae sa tupa. E il più spesso con una certa velocità o violenza: come del cinghiale braccato dai cani e dai battitori nelle cacce, quando esce furioso dalla macchia in cui era nascosto; o d'improvviso, come la pernice scovata dal segugio nel cespuglio, ove si era ammagada.
Da tupa poi abbiamo il diminutivo tupetto, col quale si indica quella specie di lattuga che le foglie, anziché a cespo, le raccoglie una sull'altra, appunto come il già visto cavolo cappuccio, anche se in maniera meno compatta e fitta. E un accrescitivo, che però, con termine di enigmistica, dovrebbe dirsi falso accrescitivo: cioè tupone. Col quale non ci è avvenuto mai di sentir chiamare una tupa, cioè una macchia molto grande, ma solo il tappo, anche se di dimensioni ridotte. E su tupone non è sempre necessariamente un lappo di botte o di damigiana, perché il termine vale anche a indicare qualsiasi altro aggeggio idoneo a chiudere un recipiente qualsiasi. E da tupone, logicamente, tuponare, con lo stesso significato di tupare, «apporre su tapu», e istuponare, al contrario, «togliere il tappo».
Il fatto, per non dire l'azione, del cavolo a upu, o de sa tupetta che dispongono le foglie, man mano crescendo, nel modo che abbiamo visto e definito sopra, è in sardo precisato col verbo atupare. E, poi, ma con evidente corruzione, aggupare, aggupulare; gùpulu essendo chiamata la palla formata dalle foglie dell'una e dell'altra erba (lattuga e cavolo); ma non solo da esse. Così alla ricerca di funghi più di una volta ho detto (od ho sentito dire, si intende, da altri) una frase come la seguente: che so incappadu in d'una istèrrida de cugumeddos aggupulados, e nde nappo prenu una pischedda. Si tratta di funghi il cui cappello si raccoglie a cupola fin quasi a toccare il gambo.
Or è evidente, a mio parere, che nel sardo gùpulu, come nell'italiano «cupola», è presente la radicale di cui trattiamo: tup, dalla quale siamo partiti. La derivazione, peraltro, è da ritenere non diretta, ma indiretta, derivata; perché è da credere senz'altro che gùpulu e «cupola» ci vengano dal latino cupula, diminutivo di cupa, «botte».
Lo strano è che per noi la cupola non è chiamata così, ma porta il nome di zumbóina o zumbóriu, come porta lo Spano. E l'uno e l'altro vengono da zumbu, zumba, che indica una modesta gibbosità naturale o artificiale della terra, un rigonfiamento fisico, per una caduta. Nel quale zumbu, per altro, pare adombrato, a ben vedere, anche il suono e il senso della radicale tup in argomento.
Tratto da: Curiosità del vocabolario sardo, 27. Dell'«upittu de sos sorighes», di Maimone e la marcatura del tempo, di Antonio Senese - Link